 |
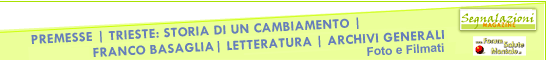 |
 |
 |
Trieste: storia di un cambiamento
"…la cosa importante è che abbiamo dimostrato che l’impossibile diventa possibile. Dieci, quindici, vent’anni fa era impensabile che un manicomio potesse essere distrutto. Magari i manicomi torneranno a essere chiusi e più chiusi di prima, io non lo so, ma ad ogni modo abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in altra maniera, e questa testimonianza è fondamentale. Non credo che il fatto che un’azione riesca a generalizzarsi voglia dire che si è vinto. Il punto importante è un altro, è che ora si sa cosa si può fare. È quel che ho detto già mille volte: nella nostra debolezza, in questa minoranza che siamo, noi non possiamo vincere perché è il potere che vince sempre. Noi possiamo al massimo convincere. Nel momento in cui convinciamo, noi vinciamo, cioè determiniamo una situazione di trasformazione difficile da recuperare."
Franco Basaglia, Conferenze brasiliane, 1979
 Nella
ricorrenza annuale della "giornata mondiale della salute", il
7 aprile 2001, la signora Gro Harlem Brundtland, general manager dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ha lanciato un messaggio a tutti i governi
affinché si adoperino, con azioni concrete e campagne di comunicazione,
per far fronte allo stigma, al pregiudizio e all’esclusione sociale che
ancora condizionano la vita delle persone che soffrono di disturbi mentali:
oltre duecento milioni di uomini e di donne, un paese grande quattro volte
l’Italia. Lo slogan “Stop exclusion. Dare to care” (contro
l’esclusione, il coraggio di prendersi cura) ha segnato con forza l’invito
dell’OMS a chiudere tutti gli ospedali psichiatrici ancora attivi, sia
nei paesi ricchi che in quelli poveri.
Nella
ricorrenza annuale della "giornata mondiale della salute", il
7 aprile 2001, la signora Gro Harlem Brundtland, general manager dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ha lanciato un messaggio a tutti i governi
affinché si adoperino, con azioni concrete e campagne di comunicazione,
per far fronte allo stigma, al pregiudizio e all’esclusione sociale che
ancora condizionano la vita delle persone che soffrono di disturbi mentali:
oltre duecento milioni di uomini e di donne, un paese grande quattro volte
l’Italia. Lo slogan “Stop exclusion. Dare to care” (contro
l’esclusione, il coraggio di prendersi cura) ha segnato con forza l’invito
dell’OMS a chiudere tutti gli ospedali psichiatrici ancora attivi, sia
nei paesi ricchi che in quelli poveri.
In un opuscolo, distribuito il 7 aprile, si scriveva tra l’altro:
"…In Italia la legge di riforma del 1978 ha dato avvio a un processo
di superamento degli ospedali psichiatrici, con la creazione di servizi
centrati sulla comunità che permettono ai pazienti di condurre
la loro vita in contesti sociali normali. La città italiana di
Trieste ha creato una significativa rete di servizi basati sulla comunità,
appartamenti protetti e cooperative che danno lavoro a pazienti psichiatrici.
L’ospedale psichiatrico di Trieste è stato chiuso e sostituito
da servizi territoriali operanti 24 ore su 24. Questi centri forniscono
assistenza sanitaria, riabilitazione psicosociale, assistenza sociale
e, se necessario, trattamenti per episodi acuti. Un certo numero di appartamenti
protetti, che offrono un ambiente amichevole e non medicalizzato, sono
stati creati per i pazienti cronici e più gravi. Infine, le opportunità
di lavoro hanno permesso a molti pazienti di assicurarsi un’integrazione
effettiva nell’ambiente sociale…"
Questo giudizio, così lusinghiero per Trieste, rappresenta il compendio
di un lavoro di trasformazione condotto nell’arco di trent’anni. La storia
di questo lungo percorso non è ancora stata scritta, anche se esiste
un grande archivio; proviamo, nei paragrafi che seguono, a ricostruirne
per sommi capi alcune sequenze, tracce di ricerca e di memoria.
Il superamento dell’ospedale psichiatrico
Agosto 1971, Franco Basaglia assume la direzione dell’ospedale psichiatrico
di Trieste. Nell’accettare l’incarico si adopera per costituire un gruppo
di lavoro formato da giovani medici, sociologi, assistenti sociali, volontari
e studenti provenienti da diverse città e regioni, italiane ed
europee. Molti sono attratti a Trieste dall’importanza che il discorso
intorno alla psichiatria e alle istituzioni totali va assumendo in quegli
anni nei movimenti sociali e di opinione, negli organi di informazione
e nel dibattito politico.
Il modello della comunità terapeutica, sviluppato in maniera originale
a Gorizia da Basaglia e dalla sua équipe nel decennio precedente,
ha assunto una risonanza nazionale dopo la pubblicazione de L’istituzione
negata (1968). In quel libro, mentre si documentano gli sforzi per umanizzare
l’istituzione, si denuncia per la prima volta il fatto che l’ospedale
psichiatrico non può essere riformato: obbedendo a regole e leggi
di ordine pubblico e controllo sociale, non può soddisfare obiettivi
di assistenza e di cura, essendo anzi produttore di malattia.
A Trieste si dovrà dunque procedere nel solco tracciato da Gorizia
per andare oltre il manicomio: trasformarne l’organizzazione non per riformarla,
ma per superarla attraverso la costruzione di una rete di servizi territoriali,
alternativi e sostituivi delle molteplici funzioni ? di cura, ospitalità,
protezione e assistenza ? assolte dall’ospedale.
La sfida è difficilissima: malgrado le numerose esperienze riformatrici
avviate anche in Francia e in Inghilterra nel secondo dopoguerra, nessuno
è mai riuscito a spostare realmente l’asse delle cure dall’ospedale
alla comunità. Non esistono saperi o pratiche consolidate cui ispirare
il processo riformatore; né le norme giuridiche e legislative di
cui si dispone, ancora basate sul giudizio di pericolosità del
malato di mente, sono di per sé sufficienti ad autorizzare una
vera apertura e civilizzazione delle funzioni di cura della psichiatria
in senso territoriale e comunitario.
Sulla "distruzione dell’ospedale psichiatrico", come "fatto
urgentemente necessario", Basaglia aveva scritto nel 1964:
“Dal momento in cui oltrepassa il muro dell’internamento, il malato
entra in una nuova dimensione di vuoto emozionale (risultato della malattia
che Burton chiama institutional neurosis, e che io chiamerei semplicemente
istituzionalizzazione); viene immesso, cioè, in uno spazio che,
originariamente nato per renderlo inoffensivo ed insieme curarlo, appare
in pratica come un luogo paradossalmente costruito per il completo annientamento
della sua individualità, come luogo della sua totale oggettivazione.
Se la malattia mentale è, alla sua stessa origine, perdita dell’individualità,
della libertà, nel manicomio il malato non trova altro che il luogo
dove sarà definitivamente perduto, reso oggetto della malattia
e del ritmo dell’internamento. L’assenza di ogni progetto, la perdita
del futuro, l’essere costantemente in balia degli altri senza la minima
spinta personale, l’aver scandita e organizzata la propria giornata su
tempi dettati solo da esigenze organizzative che – proprio in quanto
tali – non possono tenere conto del singolo individuo e delle particolari
circostanze di ognuno: questo è lo schema istituzionalizzante su
cui si articola la vita dell’asilo".
Il cambiamento dell’organizzazione interna
Al 31 dicembre 1971 risultano ricoverate a Trieste 1182 persone, con
un turnover annuo di circa 1300 pazienti, più del 90% dei quali
subisce un ricovero coatto (L.36/1904); sono molto pochi coloro che usufruiscono
del ricovero volontario, introdotto di recente nella legislazione italiana
(L.431/1968). Proprio l’uso del ricovero volontario, che a Trieste viene
enfatizzato dalla nuova équipe, diventa strumento di fondamentale
importanza per non sottrarre ai pazienti i loro diritti: non solo per
accrescere la loro libertà di movimento dentro e fuori l’ospedale,
ma anche per attribuire ai ricoverati un potere di interlocuzione nel
miglioramento delle cure e dell’assistenza.
Già dai primi mesi del ’72 molta attenzione viene riservata al
cambiamento organizzativo degli spazi interni, con la messa in crisi delle
rigide gerarchie professionali che regolano i gruppi di lavoro nel rapporto
tra operatori e pazienti. La trasformazione è inizialmente immaginata
come progressivo restringimento e ristrutturazione degli spazi ospedalieri
in "comunità aperte", con la suddivisione in 5 "zone"
ed altrettante équipe, cui faranno riferimento cinque aree geografiche
della città e della provincia.
Oltre alle riunioni quotidiane di direzione, in cui tutti i gruppi di
lavoro si confrontano, in ciascuna équipe si tengono ogni giorno
incontri e discussioni con il personale; in periodiche assemblee, coordinate
da Basaglia, i pazienti dell’ospedale vengono riuniti per discutere i
cambiamenti in atto. All’apertura delle porte dei reparti corrisponde
la soppressione delle terapie di shock e di tutti i sistemi di contenzione
fisica; viene anche abolita la divisione tra uomini e donne, e preparato
il terreno per la creazione di reparti misti.
Mentre la vita comunitaria dell’ospedale si anima di numerose iniziative
(feste, bar, giornale dei ricoverati), si moltiplicano le uscite dei pazienti
in città, sia individuali che in piccolo gruppo. Le persone vengono
così reintegrate a poco a poco nel possesso del denaro per accedere
ai luoghi pubblici, anche grazie alla erogazione di sussidi (una tantum
o mensili) deliberata, proprio agli inizi del ’72, dall’amministrazione
provinciale.
L’avvio del processo di trasformazione suscita resistenze negli infermieri
e allarme nella cittadinanza:
"… predominava l’ideologia che il matto era pericoloso e doveva
stare chiuso in manicomio. Perciò l’inizio del lavoro consisteva
nel convincere che le cose non stavano così. Giorno per giorno
abbiamo tentato di dimostrare che cambiando la relazione con l’internato
cambiava il senso di questa relazione. L’infermiere ha cominciato a convincersi
che il suo lavoro poteva essere diverso, e a diventare così un
agente della trasformazione. D’altra parte per convincere la popolazione
era necessario innanzitutto riportare il folle in strada, nella vita sociale.
Con questo abbiamo stimolato l’aggressività della città
contro di noi. Noi avevamo bisogno di creare una situazione di tensione,
per mostrare il cambiamento che stava accadendo. Col tempo la città
ha capito cosa stava succedendo. L’importante, nell’addestramento degli
infermieri, è stato che il nuovo tipo di realtà li ha portati
a non essere più dipendenti dal medico, a essere operatori che
potevano prendere decisioni in proprio"
(Franco Basaglia, Conferenze brasiliane, 1979)
La restituzione dei diritti agli internati
In quei primi anni il lavoro d’équipe si concentra sulla ricostruzione
dei bisogni e delle storie personali dei ricoverati, nel tentativo di
ricomporre il loro rapporto con le famiglie e i luoghi di provenienza.
Man mano che i grandi reparti vengono ridimensionati, si organizzano gruppi
di convivenza e gruppi appartamento: dapprima all’interno dell’ospedale,
poi in città. Lo stile di lavoro è orientato al sistematico
coinvolgimento e alla formazione degli infermieri, che devono abbandonare
la tradizionale funzione di "custodi" per assumere un ruolo
attivo e responsabile nel processo di cambiamento
Tra le diverse forme di organizzazione dei pazienti, che cominciano a
riunirsi fra di loro attorno a svariate iniziative ed attività,
assume un particolare rilievo nel 1972 la costituzione della "Cooperativa
Lavoratori Uniti" che associa circa 60 persone ricoverate, addette
a mansioni di pulizia dei reparti, delle cucine e del parco. L’attribuzione
di un regolare contratto sindacale a ogni ricoverato – lavoratore rappresenta
il risultato dell’impegno dei primi anni contro le pratiche di sfruttamento
degli internati, impropriamente denominate "ergoterapia". La
stipula del contratto e il riconoscimento della cooperativa, sostenuti
anche da uno sciopero dei degenti che lavorano presso i servizi generali
dell’ospedale, anticipano i percorsi che negli anni successivi porteranno
alla costituzione sempre più numerosa di cooperative sociali.
Il riconoscimento del diritto al lavoro, insieme alla rottura della logica
di reparto con la creazione di unità comunitarie e di convivenza,
più piccole e autonome, rendono evidente che non è la disabilità
o la malattia in sé, bensì lo statuto giuridico e amministrativo
di "internato" ad ostacolare la reale costruzione di percorsi
riabilitativi. Si apre così una vertenza con l’amministrazione
provinciale affinché la cura e l’ospitalità, diurno/notturna,
siano riconosciute come diritto anche per quelle persone che, pur non
necessitando del ricovero ospedaliero, sono ancora obbligate a risiedere
in ospedale come "ospiti" in mancanza di alternative assistenziali,
abitative e di inserimento sociale.
"In quei primi anni molta parte del lavoro consisteva nel parlare
con i familiari o coi tutori per riuscire a cambiare lo statuto del malato,
attorno al problema della restituzione dei diritti civili e delle possibilità
economiche, di reddito. Questo sforzo era l’unico che ci permettesse di
sottrarre l’esperienza delle persone alla totalizzazione psichiatrica.
Gli internati dovevano essere riconosciuti come persone dotate di identità
altra, che non si esauriva nel loro essere oggetti dell’istituzione e
oggetti della psichiatria. Noi sostenevamo di non poterci neppure confrontare
con loro, se prima non fosse stato loro restituito lo statuto di cittadini"
(da un’intervista a Franco Rotelli, 1978)
La costruzione del rapporto tra ospedale e territorio
Benché l’attività degli operatori continui ad avere il
proprio baricentro nell’istituzione, già a partire dal ’73 le pratiche
sono fortemente proiettate all’esterno, nella ripresa del rapporto con
le famiglie, nel portare i ricoverati in città, nel reperimento
di lavoro e di alloggi per i dimissibili. Parallelamente l’ospedale si
apre sempre più all’ingresso della città: collettivi d’arte,
feste e concerti richiamano la popolazione nello spazio di San Giovanni.
È in questa fase che si gettano le basi di una conoscenza e di
un’alleanza tra l’esperienza psichiatrica e i soggetti sociali: gruppi
di giovani, movimenti delle donne e degli studenti, organizzazioni politiche
e sindacali, organi di informazione e di opinione, intellettuali ed artisti.
Nel primo reparto vuoto ("P") si organizza un laboratorio di
pittura, scultura, teatro, scrittura, in cui si costruisce "Marco
Cavallo": un grande cavallo azzurro, di legno e cartapesta, simbolo
del desiderio di libertà di tutti gli internati, che l’ultima domenica
di marzo del ’73 viene portato per le vie della città in testa
a un corteo di operatori e di pazienti, di artisti e di cittadini. Sempre
più frequentemente si organizzano soggiorni in località
di villeggiatura e uscite in gruppo per partecipare alle normali attività
della città.
Fra il ’73/74 l’organizzazione dell’ospedale viene ulteriormente trasformata,
adeguando il criterio, definito già nel ’72, di sistemare i pazienti
nei reparti non per gravità (agitati, violenti, sudici, infermi,
cronici) ma per provenienza, in base a una ripartizione dell’area urbana
e provinciale in "zone" che sono rimaste le stesse nel corso
degli anni (corrispondenti agli attuali quattro distretti sanitari e ai
relativi Centri di Salute Mentale). Si dà così inizio a
uno stile di lavoro che ha come obiettivo la dimissione e il sostegno
del paziente nel proprio domicilio e contesto di vita; anche la presa
in carico di nuovi casi viene sempre più fatta dipendere dalla
ricerca di un rapporto di collaborazione con enti, istituzioni e cittadini
dell’area di riferimento.
Il lavoro all’esterno dell’ospedale ? tra resistenze, successi, conflitti
? introduce i primi e più significativi cambiamenti nella pratica
terapeutica e nell’assetto istituzionale, gerarchico e amministrativo,
diventando una scuola di formazione sul campo per infermieri e medici.
La nascita dei primi centri territoriali
All’inizio del ’75 i ricoverati sono 800, di cui 90 coatti, 150 volontari
e 460 ospiti; il turnover è di circa 1700 pazienti. Molti dimessi
hanno già trovato collocazione all’esterno: qualche volta in famiglia,
più spesso in gruppi appartamento e in abitazioni autonome, ottenute
in affitto dall’ente case popolari.
I primi presidi territoriali vengono attivati tra il ’75 e il ’76: si
tratta di strutture inizialmente finalizzate al supporto dei pazienti
dimessi dall’ospedale psichiatrico, ma quasi subito vengono utilizzate
nella presa in carico di pazienti in crisi. Funzionanti come centri di
riferimento diurno, hanno l’effetto di ridurre in modo consistente il
numero dei nuovi ingressi in ospedale, oltre che la frequenza e la durata
dei ricoveri.
I primi Centri di Salute Mentale nascono dunque in anticipo rispetto alla
legge 180, e riescono a svilupparsi malgrado un regolamento frammentario
e riferimenti legislativi poco saldi; solo la già citata legge
431/1968 permette un’incerta validazione delle nuove strutture, in analogia
alla normativa dei Centri di Igiene Mentale che essa aveva introdotto.
Intanto è ancora attiva l’organizzazione dell’ospedale psichiatrico,
ed è questo il momento più delicato e difficile del processo
di trasformazione, nel quale convivono due modelli organizzativi e culturali
di assistenza, due modalità di spesa, due orientamenti per la gestione
degli infermieri. Il rischio è la paralisi. Questo "passaggio
cerniera" verrà superato con la scelta di investire e qualificare
l’assistenza territoriale, la crescita e il rafforzamento progressivo
dei Centri di Salute Mentale aperti 24 ore su 24.
Agli inizi del ’77 i ricoverati scendono a 132, di cui 51 coatti e 81
volontari; gli ospiti sono 433. Nel febbraio dello stesso anno viene istituito
un servizio di guardia psichiatrica con reperibilità 24 ore su
24 presso il pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore, con l’obiettivo di
filtrare la domanda psichiatrica, trovare soluzioni più adeguate
alla crisi, contrastare il ricorso automatico e routinario al ricovero
coatto. Il servizio resterà in funzione fino al 1980, allorché
? dopo l’emanazione della legge 180 ? sarà trasformato in Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura con funzioni di pronto soccorso psichiatrico,
consulenza presso i reparti ospedalieri e smistamento della domanda nei
Centri di Salute Mentale competenti per territorio.
Verso la fine del 1976, all’entrata in crisi della giunta provinciale
che sotto la guida di Michele Zanetti aveva sostenuto fino a quel momento
il processo riformatore, Basaglia decide di annunciare pubblicamente la
chiusura dell’ospedale psichiatrico come fatto ormai irreversibile:
"Risultato importante per noi è che i Centri territoriali,
non esorcizzando il livello talora precario delle loro pratiche, diventano
sempre di più dei luoghi di incontro di ex – internati, nuova utenza
e cittadini altri: figure che, se non hanno d’acchito un comune codice
di riferimento, scoprono progressivamente il terreno della loro alleanza
sostanziale nell’emergere di bisogni e di oppressioni comuni. L’altro
fatto importante è che la cosiddetta "gestione del malato"
sembra uscire dal significato totalizzante che ricopriva dentro l’ospedale:
l’assunzione totale della persona, l’amministrazione completa della sua
vita. La fine della tutela, l’inizio del contratto, significano anche
la fine di questo tipo di gestione: l’avvio della reciprocità del
discorso, la possibilità di opporsi"
(La chiusura dell’ospedale psichiatrico, Conferenza Stampa, 1976)
La chiusura dell’ospedale psichiatrico
Il 13 maggio 1978, sotto la spinta dei processi di deistituzionalizzazione
in atto a Trieste e in altre parti d’Italia, dietro la minaccia di un
referendum abrogativo della legge 36/1904 e di un conseguente vuoto legislativo,
viene approvata la legge 180 che decreta il graduale superamento degli
ospedali psichiatrici a vantaggio di un modello di assistenza territoriale
radicalmente innovativo. Al momento della promulgazione della legge le
strutture più protette e di reparto dell’ospedale psichiatrico
di Trieste sono quasi completamente smantellate e il turnover ridotto
al minimo, con un’accettazione che ha già di fatto quasi cessato
le sue funzioni.
Nel novembre del 1979 Franco Basaglia lascia Trieste e si trasferisce
a Roma, chiamato a dirigere i servizi psichiatrici nella regione Lazio;
direttore incaricato è Franco Rotelli al quale spetta il compito
non facile di chiudere definitivamente l’ospedale psichiatrico, il cui
"stato di confusione e di abbandono" è oggetto di attacchi
e di denunce, anche penali. Soprattutto la nuova direzione deve rafforzare
una vasta compagine di servizi e di interventi territoriali ancora scarsamente
definiti, sia dal punto di vista amministrativo che nell’assetto e nell’attribuzione
delle risorse. Sono anni di transizione organizzativa, in cui il governo
della riforma psichiatrica dev’essere conciliato all’istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale e al trasferimento di competenze dalla Provincia all’Unità
Sanitaria Locale.
Il 21 aprile1980 l’amministrazione provinciale dichiara con una delibera
che l’ospedale psichiatrico di Trieste “può cessare dalle
sue funzioni e quindi essere soppresso". Nell’agosto dello stesso
anno muore Franco Basaglia.
L’istituzione del Dipartimento di Salute Mentale
Nel 1981 viene istituito il Dipartimento di Salute Mentale che dal punto
di vista operativo garantisce l’unità tecnica, amministrativa e
progettuale della rete dei servizi territoriali, dei loro programmi e
attività. Nelle 5 zone/aree di riferimento territoriale (diventate
4 nel 1996) vengono definiti con maggior precisione gli standard di funzionamento
dei CSM, a ciascuno dei quali compete un bacino d’utenza di circa 50.000
abitanti, con 8 posti letto e una mensa per le persone in ospitalità
diurna e diurno/notturna.
Accanto alle attività di assistenza ambulatoriale, domiciliare
e di supporto sociale, molto importante diventa l’impegno dei servizi
territoriali all’interno del carcere. Su autorizzazione del Ministero
di grazia e giustizia viene attivato un servizio di consultazione psichiatrica
presso la casa circondariale di Trieste, svolto dagli operatori dei CSM
allo scopo di garantire la continuità terapeutica per i cittadini,
già portatori di disturbi mentali, detenuti per aver commesso reato.
Il servizio favorisce l’applicazione di misure alternative alla detenzione,
evita l’induzione di pesanti carriere istituzionali, riduce l’automatismo
degli invii in ospedale psichiatrico giudiziario.
In ciascuna delle zone in cui è ripartito il territorio si rafforzano
i gruppi abitativi e residenziali, per dare ospitalità non solo
ai dimessi dall’ospedale psichiatrico, ma anche a persone che, pur non
essendo mai state ricoverate, vivono in situazioni familiari precarie
o di grave conflittualità. Si sviluppano programmi riabilitativi,
di formazione e socializzazione, ai quali partecipano gli utenti : attività
ricreative e del tempo libero, laboratori espressivi, corsi di alfabetizzazione
e scolarizzazione. Parallelamente, verso la metà degli anni ’80
aumenta il numero delle cooperative per l’inserimento al lavoro, con la
progressiva qualificazione ed estensione della gamma delle attività.
L’intervento delle cooperative sarà sempre più rivolto,
anche negli anni seguenti, a costruire percorsi di emancipazione per persone
? giovani in prevalenza ? che presentano svantaggi e disabilità
di diversa natura, provenienti dall’area della psichiatria, della tossicodipendenza,
della marginalità sociale. Il rafforzamento della loro azione,
in una prospettiva di "impresa sociale", coinciderà negli
anni ’90 con un lavoro molto significativo, teorico e pratico, condotto
dall’intero DSM per l’esercizio pieno dei diritti di cittadinanza degli
utenti dei servizi di salute mentale. I programmi abilitativi e di emancipazione
? centrati sull’habitat, il lavoro, la socialità, l’istruzione,
la formazione ? tenderanno ad essere sempre più finalizzati alla
costruzione di reti, gruppi di incontro e di autoaiuto, mirati a fasce
di popolazione a rischio (soprattutto i giovani e le donne).
Dati e risultati del processo di deistituzionalizzazione
Da più di 20 anni Trieste vive senza manicomio e il numero delle
persone che si riferiscono ai servizi nel corso di un anno è mediamente
del 13,5 per mille della popolazione (3500 utenti/anno). Non è
molto sviluppato il settore della psichiatria mercantile, non si sono
verificati fenomeni di trasferimento e deposito delle persone in altre
istituzioni (transistituzionalizzazione), se si esclude il ricorso ai
reparti di medicina generale e di geriatria di persone anziane affette
da malattie organiche, concomitanti a disturbi mentale. Dopo la creazione
nei primi anni ’80 del Servizio per le Tossicodipendenze, molti programmi
indirizzati a persone dipendenti da alcool e droghe illegali sono sviluppati
in collaborazione con il DSM (cooperative, laboratori, tempo libero, sport).
Attualmente il Comprensorio di San Giovanni ospita meno di 50 persone
in alcune piccole residenze; dal 1980 nessun paziente è stato più
ricoverato. La rete dei servizi è costituita da 4 Centri di Salute
Mentale per una popolazione di 247.000 abitanti. Dal 1999 la Clinica psichiatrica
universitaria è parte integrante del DSM e ha attivato un Centro
di Salute Mentale. La spesa per l’assistenza psichiatrica si è
dimezzata: alla fine del 1971 il bilancio consuntivo dell’Amministrazione
Provinciale ammontava a più di 5 miliardi, circa 26 milioni di
euro; a chiusura del bilancio dell’Azienda sanitaria nel 2001 il DSM è
costato 26,5 miliardi di lire, poco meno di 14 milioni di euro (il costo
del denaro nel frattempo è aumentato di circa 12 volte).
La riduzione complessiva del personale, registrata nel corso degli anni,
porta dalle 524 unità nel 1971 alle 235 unità del 2001;
la riduzione dei posti letto è a sua volta passata dai 1.160 posti
letto ospedalieri nel 1971, a 140 posti letto variamente distribuiti nel
territorio e con funzioni differenziate (SPDC, CSM, Clinica, Residenze).
Il ricorso al privato è molto contenuto: 90 triestini, pari al
2% dell’utenza, sono stati ricoverati nel 1999 in cliniche private fuori
regione. Infine, un unico luogo di cura, il manicomio, è stato
sostituito da poco meno di 40 differenti strutture con funzioni e compiti
diversificati.
Se questi indicatori di risorse e di popolazione mostrano il cambiamento
istituzionale e strutturale, alcuni risultati restituiscono il senso del
processo di deistituzionalizzazione, facendo giustizia di molti luoghi
comuni e pregiudizi che si sono sedimentati attorno all’idea della chiusura
dell’ospedale psichiatrico:
– il numero di persone ricoverate in ospedale psichiatrico giudiziario
erano più di 24 nel 1971, e in media 20 negli anni ’70; attualmente
si registrano due soli casi nel 2001, e in media 0,5 nel corso degli ultimi
dieci anni (pregiudizio della pericolosità);
– il numero dei ricoveri coatti era mediamente di 150 negli anni ’70 (60
per 100.000 abitanti), mentre ci sono stati 20 Trattamenti Sanitari Obbligatori
nel 2001, e negli ultimi 20 anni la media si è tenuta intorno a
8 TSO per 100.000 abitanti per anno (pregiudizio del rifiuto delle cure);
– erano 50 i suicidi registrati nel 1971, sono stati 43 nel 2001, con
un tasso del 17,4/100.000 a fronte di un tasso medio di 23/100.000 nel
periodo 1985 – 1996 (pregiudizio dell’abbandono).
Verso nuovi scenari
Valutando il lavoro territoriale degli ultimi vent’anni, l’indicatore
che forse più di tutti dà ragione all’organizzazione territoriale
dei servizi è la presa in carico della crisi e la sua evoluzione.
L’approccio non burocratico agli stati di crisi, al di fuori del modello
medico, ha ridotto e tende a ridurre ? se non a rendere inutile ? il ricorso
ai ricoveri ospedalieri, favorendo un più rapido ristabilimento
di condizioni di equilibrio. Oltre a diminuire il rischio di ricadute,
la crisi resta un evento che è parte della storia delle persone,
con un proprio significato che va compreso e ricostruito, e un bisogno
che va preso in carico attivando e finalizzando risorse e legami del contesto.
Intendiamo qui riferirci ad attitudini e stili operativi propri di un
servizio territoriale che, distanziandosi dal modello clinico, si concretizzano
in una disposizione del servizio ad andare incontro al paziente: un’accoglienza
al di fuori di tempi e spazi clinico – ospedalieri, senza utilizzare filtri
e competenze rigide, standardizzate. Un servizio che sappia valorizzare
la rete dei rapporti sociali, insistere sulla qualità e sulle abilità
delle persone piuttosto che sui sintomi. Che non definisce protocolli
e tempi di ricovero, ma presta la massima cura nel progetto, mantenendo
elevata la qualità degli spazi, degli arredi, della pulizia, del
cibo, in quanto decisiva per la qualità delle relazioni.
Nel corso degli ultimi cinque anni si sono stabilmente organizzati programmi
di cui gli utenti sono protagonisti: gruppi di autoaiuto che fanno capo
a giovani associati in club con sede propria; programmi di informazione
e organizzazione dell’aiuto reciproco per i familiari; un programma che
fonda la sua attività sulla valorizzazione delle differenze di
genere. Insieme al forte sviluppo delle cooperative sociali, che lavorano
in una prospettiva di "impresa sociale", questi programmi sarebbero
impensabili al di fuori del coinvolgimento e della partecipazione dell’utenza.
Un’altra area progettuale che si va evolvendo e strutturando, e che rappresenta
forse uno dei punti di maggior rottura con il passato e di anticipazione
di sviluppi futuri, riguarda la formazione. I programmi spaziano dall’informatica
all’editoria, dalla comunicazione sociale all’educazione civica, dalla
moda alla gestione di un’emittente radiofonica, in una gamma che ogni
anno si diversifica e si allarga. In futuro, non solo a nostro parere,
l’educazione svolgerà un ruolo preminente nella costruzione di
percorsi di sviluppo sostenibile per le persone e il loro habitat.
Questi scenari ? impresa sociale, autoaiuto, partecipazione dei familiari,
differenza di genere, formazione ? costituiscono, all’interno della rete
dei servizi, gli indicatori che meglio di altri restituiscono la tensione
dei servizi e degli operatori verso la costituzione delle nuove istituzioni
per la salute mentale.
Il Comprensorio di San Giovanni
A partire dagli anni ’70 il vasto complesso architettonico denominato
"Comprensorio di San Giovanni", costruito all’inizio del ‘900
da Ludovico Braidotti per contenere all’interno di una cinta muraria il
"grande innovativo asilo per alienati", il "magnifico frenocomio
civico di Trieste", è stato via via restituito alla città.
Oggi sono numerose le istituzioni e i servizi che hanno preso il posto
dei vecchi reparti: oltre a facoltà e uffici dell’Università
degli Studi di Trie¬ste, situati in sei palazzine, vi sono due scuole
superiori con lingua d’insegnamento slovena, la sede dell’Istituto Nautico
Internazionale, quella di Medicina del Lavoro, e una del Teatro Comunale.
Un ex-padiglione è utilizzato come centro diurno del servizio per
persone disabili del Comune. Nel Comprensorio sono collocati anche il
Dipartimento delle Dipendenze e la sede del Distretto 4, con i servizi
ad esso collegati.
Vi si sono trasferiti nel corso dell’ultimo anno, la Direzione Generale
dell’Azienda con tutti gli uffici amministrativi e il Dipartimento di
Prevenzione.
Gli edifici a tuttora utilizzati dal Dipartimento di Salute Mentale sono
dieci: oltre alla sede della Direzione, alcune "casette" sono
adibite a residenze terapeutico – riabilitative, mentre l’ex-reparto M
ospita il Politecnico, il Servizio Abilitazione e Residenze, gli uffici
di alcune cooperative sociali. Molto attivo e frequentato da una vasta
clientela è lo storico bar – ristorante “Il posto delle fragole”.
Nella contiguità di molti soggetti che lo popolano, e di molte
pratiche lo attraversano, il Comprensorio di San Giovanni continua a rappresentare
un luogo di convivenze e di multiappartenenze, con una forte identità
storica. Paesaggio emblematico, oltre che splendido, che esige particolari
attenzioni gestionali e che dovrebbe essere sempre più qualificato
dal programma di accordo tra gli enti per un uso multifunzionale e coordinato
dell’area.
L’opportunità di istituire una giardineria che governi spazi verdi
e percorsi comuni, creando un parco pubblico molto utile alla vita della
città, è stata sottolineata in uno studio condotto dalla
Fondazione Benetton. Nella ricerca, oltre ad evidenziare l’enorme valore
di natura e di memoria contenuto in quest’area, si chiede alla città
di assumere questo pezzo della comunità come componente preziosa
della civitas triestina: crogiuolo di tensioni e di utopie, laboratorio
di culture della tolleranza.